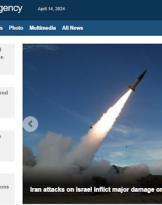Il primo ministro, Liz Truss, lascia il numero 10 di Downing Street dopo soli 45 giorni di governo, doveva diventare la nuova Thatcher, invece è stata paragonata presidenti del consiglio italiani del passato, con i loro esecutivi “balneari”.
È indubbio che il Regno Unito stia vivendo un periodo di crisi di leadership che hanno pochi precedenti nella sua storia recente. Sembrerebbe (usiamo il condizionale) che tale debolezza sia scaturita dalla Brexit del 2016. È altresì opportuno ricordare come la Gran Bretagna sia entrata nell’Unione Europea.
All’indomani della Seconda Guerra Mondiale, Londra si ritrovava senza più un impero, alla ricerca quindi di un ruolo strategico che vedeva il Paese stringere un’alleanza particolare con gli Stati Uniti e, al contempo, strizzare l’occhio a un’Europa continentale non ancora vincolata nell’Unione Europea. In questo periodo il Regno Unito si assicura di avere, grazie anche all’assistenza americana nella costruzione di un arsenale nucleare, le forze armate più efficienti del Vecchio Continente e, soprattutto, la volontà di utilizzarle al fine di garantire gli interessi strategici nazionali.
D’altronde il legame “speciale” tra Londra e Washington ha radici storiche e linguistiche, come del resto quello con il resto dell’Europa.
L’adesione alla CEE (Comunità Economica Europea) da parte del Regno Unito venne fortemente osteggiata dalla Francia del generale Charles de Gaulle, il quale puntava ad una Comunità dominata da Parigi e una adesione britannica avrebbe certamente complicato i piani francesi, in quanto il generale/presidente credeva che una volta aderito alla CEE gli inglesi avrebbero continuato la loro secolare politica (balance of power) finalizzata a creare alleanze per controbilanciare le posizioni francesi. In pratica non voleva una nazione che avesse idee economiche completamente diverse dagli altri paesi europei: la finanza inglese era dominata dall’alta finanza, con pochissima influenza dello Stato, quella francese era esattamente l’opposto.
Poi c’erano gli americani, de Gaulle voleva creare una Unione forte anche dal punto di vista politico. La presenza inglese poteva significare la possibilità di Washington di influire sulle decisioni collettive.
Tuttavia, nel 1973, gli inglesi entrarono a far parte della CEE, senza comunque abbracciare il progetto con particolare entusiasmo. Infatti i successivi anni (fino al 2016) vennero passati a resistere ad ogni forma di integrazione europea, osteggiando intensamente l’asse Parigi-Berlino, vero deus ex machina dell’Unione Europea. Diciamo che questa ambivalenza ha giovato agli inglesi, potendo contare su una stabilità dell’economia senza comunque rinunciare alla loro politica estera (principalmente filo americana).
Il rifiuto di aderire alla moneta unica, in insieme alla Svezia e alla Danimarca, era finalizzato al mantenimento dell’autonomia economica, proprio il fattore economico è stato la causa scatenante della Brexit nel 2016.
La crisi del 2008 sollevò non pochi interrogativi circa la validità della globalizzazione. Il Regno Unito cominciò a vedere diminuire il proprio benessere e una maggiore integrazione economico/politica nella UE, per contrastare la crisi economica, appariva come una inaccettabile limitazione alla sovranità nazionale. C’è da dire che una categoria di lavoratori inglesi, soprattutto artigiani, ha visto nella immigrazione dagli altri paesi UE una concorrenza sleale alla quale non potevano far fronte.
La Brexit è passata (di misura) principalmente per il voto favorevole della classe operaia, la quale vedeva minacciato il proprio reddito dall’afflusso di lavoratori dell’Est Europa che erano disposti ad accettare salari più bassi.
Dopo il 2016 Londra si è legata maggiormente agli Stati Uniti, con motivazioni sensibilmente differenti rispetto al periodo della Guerra Fredda. Questa volta c’è di mezzo il riposizionamento americano verso il Pacifico, in funzione anticinese. Per mantenere saldo tale legame i britannici dovranno sostenere le grandi strategie della superpotenza, anche dal punto di vista militare (le portaerei della classe Queen Elisabeth sono funzionali a un possibile dispiegamento nel Pacifico Meridionale).
Ricordiamo che il Regno Unito è parte del c.d. Five Eyes, ovvero la rete di intelligence che coinvolge anche gli Stati Uniti, il Canada, la Nuova Zelanda e l’Australia. Questa rete permette di condividere una massa di informazioni (militari, politiche, economiche, cyber, etc.) sconosciute al resto dei paesi sviluppati.
Allo stato attuale, in termini militari, economici e politici, il Regno Unito conserva il suo status di media potenza.
Ma cosa accadrebbe se, con il referendum del prossimo anno, la Scozia dovesse staccarsi dal Regno Unito?
Innanzi tutto dal punto di vista della difesa dell’Isola sarebbe un grave problema, in quanto nella base di Faslane, 40 km a ovest di Glasgow, ci sono i sommergibili SSBN (classe Vanguard - foto apertura) i quali sono equipaggiati con i missili balistici UGM-133A Trident II, unica capacità di deterrenza nucleare del Paese. Si tratta di una posizione strategica, in quanto i battelli nucleari hanno un accesso rapido al Mare del Nord, regione strategica per il Regno Unito. Inoltre, non sarebbe facile trovare un’altra collocazione per i Vanguard, senza il rischio da parte di Londra di perdere il suo deterrente nucleare.
In sintesi, con la Scozia indipendente, Londra vedrebbe notevolmente ridotte le sue capacità militari, con la perdita di oltre il 30% del suo territorio. Inoltre, un successo del referendum scozzese potrebbe fare da volano per le recrudescenze indipendentistiche dell’Irlanda del Nord e del Galles.
Insomma, la ormai endemica debolezza dei governi di Londra e la scomparsa della regina Elisabetta II (difficilmente il figlio Carlo potrà esercitare la stessa influenza sui britannici) potrebbero aprire la strada alla dissoluzione del Regno Unito.
Foto: UK MoD