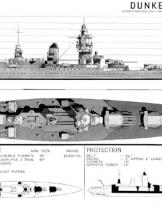Nel precedente pezzo, un mese fa, ci eravamo lasciati con la domanda: perché i prigionieri italiani in mano agli inglesi non furono liberati dopo l’8 settembre 1943, data di inizio della “cobelligeranza”? Perché il Governo inglese si rifiutò di rimpatriarli persino dopo la fine del conflitto? (v.articolo)
Cercheremo le risposte esaminando le vicissitudini trascorse da mio padre (nella foto, primo a dx seduto) ed estendendole, per analogia, alle migliaia di altri prigionieri.
Non nascose mai di essere stato fascista… del resto allora lo erano tutti o quasi. Pertanto a Zonderwater mantenne fede al giuramento prestato e - dichiarandosi non collaboratore - fu tenuto in un blocco speciale e in condizioni generali e di vitto più severe. Anche dopo l’8 settembre, quando tra i prigionieri si aprì il dibattito sul come comportarsi o con chi schierarsi, rimase fermo sulle sue posizioni. Del resto le informazioni che arrivavano al campo erano distorte dalla propaganda di ambo le parti e per i più era difficile capire perché si era iniziato in un modo e si finiva in un altro.
Ritengo che la svolta avvenne nel maggio del ‘44 quando, con cartolina postale per prigionieri di guerra, gli arrivò la triste notizia che mio nonno Salvatore, noto “Tziu Bovoreddu”, era deceduto 4 mesi prima, il 20 gennaio! Subentrò lo scoramento e lo sconforto, forse il rimpianto per un ultimo abbraccio mai dato o per un chiarimento mai avvenuto.
 L’idea di allontanarsi da quel luogo, oppure l’illusione di poter accorciare il tempo del rientro, diventò ossessionante; chiese di conferire con il responsabile del campo... probabilmente gli fecero firmare un modulo… fatto sta che due mesi dopo si ritrovò inserito in una lista di altri 444 pows (prisoners of war, ndr) destinati in Gran Bretagna (foto seguente).
L’idea di allontanarsi da quel luogo, oppure l’illusione di poter accorciare il tempo del rientro, diventò ossessionante; chiese di conferire con il responsabile del campo... probabilmente gli fecero firmare un modulo… fatto sta che due mesi dopo si ritrovò inserito in una lista di altri 444 pows (prisoners of war, ndr) destinati in Gran Bretagna (foto seguente).
Salpò da Città del Capo il 27 Agosto 1944 con la motonave SS Nieuw Amsterdam (foto). Dopo circa 15 giorni sbarcarono a Glasgow. Il 14 settembre fu registrato in ingresso al Loodge Moor Camp n.17 in Sheffield con la qualifica di joiner (falegname). Un mese dopo (il 14 ottobre) fu trasferito al Mellands Camp n.126 nel quartiere Gorton di Manchester.
Quella con gli inglesi fu una “buona prigionia”, sicuramente migliore del rude comportamento dei soldati australiani che lo avevano depredato del suo orologio e lasciato 5 giorni senza bere obbligandolo a sorseggiare le sue urine. Certamente superiore a quello delle guardie indiane ed egiziane nelle “gabbie” di Geneifa, lungo il canale di Suez, che dalle altane si divertivano a lanciare scatolette di carne o pacchetti di sigarette per il solo gusto di vedere i prigionieri italiani azzuffarsi tra loro. Migliore anche del trattamento subito in Sudafrica ove, sebbene con l’arrivo del nuovo comandante Prinsloo le condizioni generali si potessero definire molto buone, c’era quel reticolato del blocco 4 dal quale per tre lunghi anni non era mai potuto uscire.
 Al Mellands Camp n.126 di Manchester non c’era reticolato, andava a lavorare in una falegnameria ove costruivano infissi per gli edifici pubblici bombardati dai tedeschi, le domeniche si poteva uscire entro un raggio di due miglia dal campo, frequentare qualche pub a loro “riservato”. L’unica cosa vietata era importunare le ragazze locali; per il reato di fraternizing si poteva essere condannati fino a due anni di carcere, anche nei casi in cui la donna confessasse di aver provocato il pow o affermasse di volerlo sposare (per fare un esempio, il 21 settembre 1944, un prigioniero italiano venne condannato a sei mesi solo per aver scritto lettere d’amore a una ragazza sedicenne!).
Al Mellands Camp n.126 di Manchester non c’era reticolato, andava a lavorare in una falegnameria ove costruivano infissi per gli edifici pubblici bombardati dai tedeschi, le domeniche si poteva uscire entro un raggio di due miglia dal campo, frequentare qualche pub a loro “riservato”. L’unica cosa vietata era importunare le ragazze locali; per il reato di fraternizing si poteva essere condannati fino a due anni di carcere, anche nei casi in cui la donna confessasse di aver provocato il pow o affermasse di volerlo sposare (per fare un esempio, il 21 settembre 1944, un prigioniero italiano venne condannato a sei mesi solo per aver scritto lettere d’amore a una ragazza sedicenne!).
Tuttavia la prigionia in Gran Bretagna, buona dal punto di vista materiale, risultò devastante dal punto di vista psicologico; gli inglesi infatti trattennero i prigionieri italiani, fino alla conclusione del raccolto dell’autunno 1945, con la complicità dei governi dell’Italia post-fascista (da Badoglio a De Gasperi passando per Bonomi e Parri), i quali per le difficoltà di reinserimento e in ragione di quella che era considerata una “buona detenzione”, non li reclamarono mai energicamente ed immediatamente. Pertanto se prima dell’armistizio la prigionia era stata sopportabile, grazie alla convinzione che prima o poi la guerra sarebbe finita, il periodo dopo l’8 settembre 1943 fu il più lungo e doloroso.
Nella visione di mio padre, mentre il rude e disumano comportamento di australiani, egiziani, indiani e sudafricani rientrava in una giustificata logica di guerra, agli inglesi non riusciva a perdonare l’arbitraria e illegittima detenzione, considerato che da un certo momento eravamo diventati alleati o per lo meno cobelligeranti. L’8 settembre costituì quindi uno spartiacque non solo dal punto di vista psicologico, ma anche per la posizione giuridica degli italiani in cattività.
Prima di quella data lo status di prigionieri di guerra era assodato: giacché gli italiani erano nemici a tutti gli effetti, anche la prigionia era legittima e accettata. Quella condizione giuridica però non venne modificata quando l’Italia passò dalla parte degli alleati: gli italiani in mano agli anglo-americani furono tenuti prigionieri anche in seguito alla proclamazione della “cooperazione” (maggio 1944), in sostanza fino al loro rimpatrio.
La mancata modifica dello status fu dovuta a congiunte decisioni anglo-americane per cui l’Italia avrebbe dovuto rimanere un paese pienamente sconfitto, ma anche all’assenso dato dal capo del governo, generale Badoglio, ad "utilizzare prigionieri italiani in servizi non di combattimento, ma connessi con lo sforzo bellico".
La casa, nel centro storico di Orani, quattromila anime nel cuore della Barbagia, era su due livelli: al piano superiore l’abitazione mentre il piano terra era tutto dedicato alla falegnameria ove la faceva da padrona una combinata a quattro lavorazioni. Era molto rumorosa e per questo veniva messa in funzione solitamente al mattino quando eravamo a scuola per non disturbarci nel pomeriggio.
A volte però gli impegni presi Lo obbligavano a derogare e, in tal caso, interrompevo le mie traduzioni di greco o latino e facevo pausa scendendo a trovarlo.

Nei trentaquattro anni che abbiamo condiviso su questa terra non l’ho mai sentito cantare; solo due o tre volte lo sorpresi a farlo, in una di queste occasioni, con la combinata in funzione usata a guisa di base musicale o quasi a voler coprire la sua voce. La canzone era sempre la stessa e di essa cantava solo quella che più avanti negli anni imparai e scoprii essere l’ultima strofa: “Colonnello non voglio encomi/sono morto per la mia terra/ ma la fine dell’Inghilterra/ incomincia a Giarabub!”1
Ormai erano passati quasi vent’anni dal suo imbarco a Southampton per il rientro definitivo in Sardegna ma il rancore verso la perfida Albione non sembrava attenuarsi, coinvolgendo anche me in questo immaginario scontro che mi ha lasciato per diverso tempo una ingiustificata “antipatia” per questo popolo. Ovviamente oggi, col senno di poi, ho cambiato opinione su questa civilissima e multietnica nazione, patria della meritocrazia; sono convinto che avrebbe cambiato parere anche Lui se avesse potuto sapere, ad esempio, che un suo nipote ha studiato a Cambridge, vive a Londra ed è anche cittadino Britannico!
Sta di fatto che il 25 aprile 1945, mentre in Italia si festeggiava la Liberazione, circa 150.000 soldati italiani si trovavano ancora sparsi in più di duecento campi di prigionia disseminati sull’intero territorio della Gran Bretagna (foto). Per loro il 25 aprile non significò libertà ma l’inizio di una lunga e snervante attesa. Vennero rimpatriati solo a partire dal dicembre 1945 e i più sfortunati (ad esempio parte di quelli internati a Zonderwater) dovettero aspettare addirittura gli inizi del 1947.
"Carenza di navi da trasporto", è sempre stata la giustificazione ufficiale delle autorità britanniche. "Il governo italiano ci ha dimenticati e venduti agli inglesi", era invece la convinzione di molti reduci. Quale campana ascoltare?
Intanto, perché così tanti nostri connazionali si trovavano nel cuore dell’impero britannico?
La risposta è semplice: erano stati trasferiti nelle isole britanniche dai vari fronti di guerra e dagli altri campi di prigionia ubicati in ogni angolo del mondo per sopperire alla carenza di manodopera. Insomma, grazie all’utilizzo dei prigionieri italiani – ritenuti buoni lavoratori e soprattutto meno pericolosi rispetto ai tedeschi – le autorità britanniche avevano trovato un efficace sistema sia per sopperire ai vuoti lasciati dagli inglesi che partivano per il fronte, sia per garantirsi un ritorno economico.
È sufficiente snocciolare qualche dato per capire l’importanza che i pows assunsero per l’economia britannica. Agli inizi del 1945, 60.000 lavoravano nei campi alle dipendenze del Ministero dell’agricoltura; 10.000 nelle miniere, in grosse industrie, nelle foreste e nelle segherie per conto del Ministero dei rifornimenti; circa 5.000, tra i quali mio padre, erano impiegati in lavori di costruzione per conto del Ministero dei lavori pubblici; 30.000 al Ministero della Guerra (manutenzione infrastrutture militari, custodia depositi, ecc.); 15.000 svolgevano lavori stradali, ferroviari e di trasporto carbone per il Ministero dei trasporti; 30.000 mantenevano in efficienza gli oltre duecento campi costruiti dagli stessi prigionieri o ricavati in edifici preesistenti in ogni angolo del Regno Unito in modo tale da avere la manodopera vicina ai posti di lavoro.
 Il governo britannico, quindi, ottenne beneficio dal lavoro degli italiani in due modi: da una parte, impiegandoli in mansioni connesse con lo sforzo bellico ma pagandoli meno di quanto avrebbe dovuto pagare un inglese, dall’altra, cedendoli a datori di lavoro privati a prezzi superiori rispetto al costo reale, incamerandone il relativo margine. Nel settembre 1945 il guadagno per la Cancelleria dello Scacchiere fu calcolato in circa 8 milioni di sterline mensili!
Il governo britannico, quindi, ottenne beneficio dal lavoro degli italiani in due modi: da una parte, impiegandoli in mansioni connesse con lo sforzo bellico ma pagandoli meno di quanto avrebbe dovuto pagare un inglese, dall’altra, cedendoli a datori di lavoro privati a prezzi superiori rispetto al costo reale, incamerandone il relativo margine. Nel settembre 1945 il guadagno per la Cancelleria dello Scacchiere fu calcolato in circa 8 milioni di sterline mensili!
Del fatto che la prigionia fosse del tutto immotivata ne fu consapevole anche il rappresentante italiano in Gran Bretagna, il conte Nicolò Carandini (foto). Personalità di rilievo del Partito Liberale, era stato inviato a Londra nel novembre del 1944 per mostrare agli inglesi il volto della “nuova Italia” e riallacciare quei rapporti bilaterali tradizionalmente cordiali che il fascismo aveva deteriorato. Il raggiungimento di questi obiettivi fu reso difficile dall’atteggiamento ancora diffidente tenuto dalla Gran Bretagna nei confronti dell’Italia. Sintomatico il fatto che il conte Carandini non poté mai presentare le credenziali a re Giorgio VI: gli fecero capire in tutti i modi che egli rappresentava una nazione che, per quanto “cobelligerante”, era e doveva rimanere una potenza sconfitta. Per questo non fu mai considerato Ambasciatore ma “Rappresentante Italiano”; tuttavia a partire dal 1° febbraio 1945 assunse comunque la protezione dei prigionieri di guerra, rilevando questa funzione dalla neutrale Svizzera.
Anche il Conte Carandini ebbe ben chiaro il pericolo rappresentato da un rimpatrio accelerato. Sebbene fosse perfettamente a conoscenza del dramma vissuto dai pows e del loro stato, tenuto conto della situazione interna italiana, con una disoccupazione spaventosa e l’inflazione galoppante, il ritorno prematuro di 150.000 prigionieri di guerra dalla Gran Bretagna (ma il numero sarebbe salito a 340.000 sommando i pows sparsi per tutto l’impero britannico) avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Era preferibile mantenerli lontani finché la situazione italiana non fosse migliorata; tanto è vero che al suo arrivo a Londra Carandini trovò un messaggio proveniente dal Ministero degli Affari Esteri che lo invitava a fare di tutto per evitare che questo mezzo milione di uomini (il totale dei prigionieri nelle mani anglo-americane) ci fosse restituito in blocco e nel momento più fragile e delicato della nascente democrazia con pericolosi fermenti sociali affioranti dappertutto.
Mio padre nel frattempo (era il 16 giugno 1945) fu trasferito al campo n.144 in Ruskin Avenue a Londra; ora in quell’area è ubicato il The National Archives ma un piccolo Museo all’interno e una lapide all’ingresso ne ricordano i suoi trascorsi come campo di prigionia.

Finalmente nella riunione del Directorate of pows del 26 ottobre fu deciso che il rimpatrio sarebbe iniziato a dicembre, con un ritmo continuo.
I primi 2.700 prigionieri lasciarono la Gran Bretagna a bordo della SS Malaya il 17 dicembre 1945. Alla fine del mese il numero complessivo dei rimpatriati fu di 7.000.
Con l’inizio del nuovo anno (e, guarda caso, con la fine del raccolto!), il ritmo aumentò notevolmente: 23.000 furono i rimpatri in gennaio; 19.000 in febbraio; 20.000 in marzo; 22.000 in aprile; 34.000 in maggio; 10.000 in giugno; 14.000 in luglio; 8.000 in agosto.
L’artigliere Manlio Sulis, pow n. 162782, campo 144, fu rilasciato il 3 febbraio 1946 e il giorno dopo salpò da Southhampton con destinazione Napoli. Proprio quel giorno al porto per salutare i partenti era presente la Signora Elena Carandini moglie del Rappresentante Italiano; ovviamente né mio padre né gli altri ex prigionieri se ne accorsero o furono interessati all’evento!
Sbarcarono a Napoli l’11 febbraio 1946. I dieci giorni trascorsi nel centro alloggio San Martino al Vomero per sbrigare le pratiche burocratiche dovettero sembrargli interminabili e più lunghi degli interi sei anni trascorsi fuori casa; la strafottente ignoranza di una giovane recluta addetta alla compilazione del foglio notizie che non riusciva a scrivere il nome Manlio (oggi orgogliosamente portato da uno dei miei figli), storpiandolo prima in Maglio e poi in Mallio, lo fece andare in bestia scaricando tutta la tensione repressa tanto da richiedere l’intervento di un sottufficiale per calmarlo.
Comunque sia, il 21 febbraio fu messo in libertà con una licenza straordinaria con assegni di 60 giorni e l’obbligo al termine di essa di presentarsi al Distretto Militare di appartenenza in Oristano. Il 21 sera si imbarcò sulla motonave Napoli-Cagliari ove giunse all’alba del 22.

L’arrivo ad Orani il 23 febbraio 1946 è confermato dal visto apposto dal maresciallo maggiore a cavallo Giuseppe Deschino comandante la locale stazione Carabinieri (foto).
Erano trascorsi esattamente 5 anni, 8 mesi e 22 giorni nel corso dei quali aveva praticamente circumnavigato l’intera continente africano, solcato l’atlantico da sud a nord e attraversato il mediterraneo da ovest a est per un totale di circa ventimila miglia nautiche (37.000 km!) (foto seguente).
Ad agosto il rimpatrio dei prigionieri dalla Gran Bretagna poté considerarsi concluso: sul suolo britannico rimasero circa 1.500 italiani, assunti con contratto annuale, che costituirono la testa di ponte di un successivo flusso migratorio che si verificò quando le autorità britanniche, a partire dal 1947, divennero meno restrittive in materia di immigrazione. Molti degli emigranti erano proprio ex pows che tornavano perché richiesti dai vecchi datori di lavoro o per sposare le donne inglesi con le quali avevano intrecciato relazioni (clandestine) durante la prigionia.
In sintesi, dal punto di vista italiano, il ritardato rimpatrio fu dovuto a un insieme di fattori politici ed economici: il governo, è innegabile, vedeva con preoccupazione il ritorno di migliaia di prigionieri in un paese devastato dalla guerra, in cui la disoccupazione, già alta, era destinata ad aumentare e per questo non pretese mai in modo deciso la liberazione in blocco dei circa 500.000 prigionieri in mano agli Alleati. Carandini, giocoforza, si concentrò sul cambiamento di status più che su una richiesta energica di rimpatrio, sebbene fosse più di tutti a conoscenza di quanto la situazione nei campi fosse difficile e di quanto sarebbe stato pericoloso continuare a tirare la corda.
 La Gran Bretagna, dal lato suo, aveva già deciso unilateralmente di ritardare il rimpatrio dei prigionieri per motivi prettamente economici; i pows erano assolutamente necessari per l’economia britannica, almeno fino a quando non si fosse provveduto alla loro sostituzione con i soldati inglesi a smobilitazione conclusa. Ma dietro la decisione di mantenere in prigionia contro le leggi internazionali migliaia di uomini, c’era anche la precisa volontà del governo britannico di scaricare su quegli uomini il risentimento per una guerra vinta ma rovinosa che aveva creato lutti e distruzioni.
La Gran Bretagna, dal lato suo, aveva già deciso unilateralmente di ritardare il rimpatrio dei prigionieri per motivi prettamente economici; i pows erano assolutamente necessari per l’economia britannica, almeno fino a quando non si fosse provveduto alla loro sostituzione con i soldati inglesi a smobilitazione conclusa. Ma dietro la decisione di mantenere in prigionia contro le leggi internazionali migliaia di uomini, c’era anche la precisa volontà del governo britannico di scaricare su quegli uomini il risentimento per una guerra vinta ma rovinosa che aveva creato lutti e distruzioni.
A proposito di guerre vinte o perse mi sia concesso un inciso: erano gli inizi degli anni sessanta, pochissimi possedevano un apparecchio televisivo e pertanto dopo cena, specie nella tarda primavera e d’estate, era usanza sedersi fuori dall’uscio e socializzare con i soliti argomenti. Io ero giovinetto e mi piaceva ascoltare i discorsi degli adulti senza ovviamente intervenire. Durante una discussione sui reciproci trascorsi militari - che poi era uno scontro generazionale tra mio padre e un cugino di mamma da una parte e mio nonno materno dall’altra - a quest’ultimo, classe 1886, già combattente della guerra italo-turca, poi fante nella brigata Sassari ferito e decorato nei fatti d’arme di Bosco Cappuccio (seconda battaglia dell’Isonzo), scappò la frase “noi comunque le guerre le abbiamo tutte vinte!”. Mio padre ammutolì, abbandonò la discussione, si ritirò in casa e per alcuni giorni tenne il broncio al suocero; era stato un semplice artigliere ma di questa guerra persa “contro gli inglesi” ne faceva una questione personale quasi fossa stata una sua negligenza o responsabilità alla pari di Graziani o Badoglio!!
Concludo ribadendo che la Gran Bretagna considerò sempre il lavoro dei pows come un risarcimento che l’Italia doveva pagare per le sue colpe e il nostro paese non fu in grado di opporsi.
Questa debolezza italiana, che sarebbe divenuta palese con l’imposizione del gravoso trattato di pace, era già evidente nella vicenda dei prigionieri di guerra: sfruttati da un ex nemico che alleato non aveva mai voluto esserlo, cittadini di uno stato che non era nelle condizioni di tutelarli e che temeva, in modo esagerato, il loro ritorno, i soldati italiani detenuti nel Regno Unito subirono e sopportarono incredibili sofferenze morali, in gran parte dimenticate dall’opinione pubblica e dalla storiografia italiana del dopoguerra.
Giovanni Sulis (generale di c.a. in congedo)
1 Oasi nel deserto libico, 280 km. a sud di Tobruk, presidiata da 1350 italiani e 800 libici al comando dell’allora ten. col. Salvatore Castagna, teatro di un epica resistenza (10 dicembre 1940-21 marzo 1941) durante l’operazione “Compass”.
Foto: autore / web