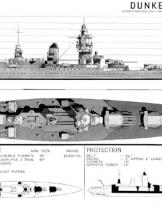La sera del 15 giugno 1815 terminava un’epoca nella quale il dio della guerra aveva trionfato sui campi di mezza Europa, solcato le onde di tutti gli oceani ed infine spento la sua passione in una banalissima pianura del Belgio. L’impero francese si sbriciolò a Waterloo e finalmente gl’inglesi, suoi irriducibili nemici, riuscirono a porre fine al dominio del “piccolo caporale”, ma soprattutto al pericolo che egli rappresentava per gli equilibri europei.
Dopo la sconfitta, l’imperatore aveva ancora qualche speranza sul suo futuro: i vincitori, sebbene con il cuore ricolmo di rabbia, non potevano trattarlo come un prigioniero qualsiasi. Le aspettative di Napoleone, tuttavia, furono presto disilluse poiché a Parigi qualcuno stava già da qualche mese preparando il futuro della Francia. Il duca d’Otranto e ministro della polizia Joseph Fouché annotava dopo Waterloo: “Fu allora che io sentì il bisogno di mettere in opera tutte le risorse a disposizione derivanti dalla mia posizione e dalla mia esperienza. La sconfitta dell’imperatore, la sua presenza a Parigi che solleva l’indignazione generale, mi mette nelle circostanze le più favorevoli per ottenere da lui l’abdicazione alla quale si oppose quando invece avrebbe potuto salvarlo”1. Fouché mentiva, poiché aveva smesso di credere in Napoleone già anni addietro, consapevole che la sua fuga dall’Isola d’Elba non avrebbe portato nulla di buono. Già durante alcuni incontri dei fatidici “Cento giorni”, l’imperatore e il duca d’Otranto erano arrivati ai ferri corti: “Voi mi tradite, signor duca d’Otranto” – ebbe a dire una volta Napoleone – “tanto vale che prendiate questo coltello e me lo affondiate nel petto, sarebbe più leale”2.
Quando rientrò nella capitale era dunque già tutto deciso: Napoleone, schiacciato dal volere del Consiglio e dalle Camere, sottoscrisse la sua seconda ed ultima abdicazione.
Un uomo come Bonaparte però non sapeva rinunciare facilmente al potere: fino all’ultimo tentò di aggrapparsi ad esso proponendosi, addirittura, come semplice generale al seguito dell’armata. Nulla però poteva più preservarlo dal suo triste destino: un esilio in un luogo sperduto dove nessuno lo avrebbe mai raggiunto e dal quale non sarebbe più potuto scappare.
Il 29 giugno, dopo ripetute insistenze da parte di Fouché e Talleyrand – i veri direttori d’orchestra del dopo Waterloo – persuasero il sovrano decaduto a imbarcarsi alla volta di Rochefort per una destinazione ancora non precisata. L’imperatore sperava di ottenere un salvacondotto verso gli Stati Uniti, ma i britannici lo temevano ancora troppo e non avevano intenzione di accettare imposizioni.
 Mentre la Francia si preparava ad accogliere il nuovo sovrano, Luigi XVIII, Il capitano Frederick Lewis Maitland camminava impaziente a bordo del vascello HMS Bellerophon, in attesa dell’ordine del suo superiore, ammiraglio George Keith. Il suo compito era quello di catturare l’orco della Corsica e trasferirlo verso luoghi più sicuri. Il capitano Maitland doveva impedire che Napoleone salpasse verso gli Stati Uniti e condurlo a Plymouth: qui si sarebbero decise le sorti del prigioniero. Già dopo Waterloo, Bonaparte temette di cadere nelle mani dei prussiani del feldmaresciallo Blücher, per questo motivo, quando la sua fine apparve inevitabile, chiese asilo all’Inghilterra. Le speranze però furono malriposte anche perché il primo ministro Lord Liverpool, non mostrò alcun favoritismo o intenzione a trattarlo con i guanti bianchi. Il capo gabinetto, dopo aver esposto il problema al parlamento, interpellò alcuni rappresentanti della Compagnia delle Indie chiedendo che l’amministrazione dell’isola di Sant’Elena passasse sotto l’egida della corona.
Mentre la Francia si preparava ad accogliere il nuovo sovrano, Luigi XVIII, Il capitano Frederick Lewis Maitland camminava impaziente a bordo del vascello HMS Bellerophon, in attesa dell’ordine del suo superiore, ammiraglio George Keith. Il suo compito era quello di catturare l’orco della Corsica e trasferirlo verso luoghi più sicuri. Il capitano Maitland doveva impedire che Napoleone salpasse verso gli Stati Uniti e condurlo a Plymouth: qui si sarebbero decise le sorti del prigioniero. Già dopo Waterloo, Bonaparte temette di cadere nelle mani dei prussiani del feldmaresciallo Blücher, per questo motivo, quando la sua fine apparve inevitabile, chiese asilo all’Inghilterra. Le speranze però furono malriposte anche perché il primo ministro Lord Liverpool, non mostrò alcun favoritismo o intenzione a trattarlo con i guanti bianchi. Il capo gabinetto, dopo aver esposto il problema al parlamento, interpellò alcuni rappresentanti della Compagnia delle Indie chiedendo che l’amministrazione dell’isola di Sant’Elena passasse sotto l’egida della corona.
L’uomo che aveva piegato ai suoi voleri i sovrani di mezza Europa, stava per finire i suoi giorni in una colonia penale britannica: un luogo infelice, sferzato da venti continui e con tasso di umidità che avrebbe lentamente eroso la sua già debole salute. All’illustre prigioniero, apostrofato con disprezzo dagli inglesi “generale Bonaparte”, fu concesso di portare con sé una corte ridotta ai minimi termini composta dai generali Bertrand, Montholon, Gourgaud e dal conte di Las Cases.
Dopo una tediosa traversata durata dieci settimane a bordo della HMS Northumberland, il comandante inglese, ammiraglio James Cockburn, intravide all’orizzonte il profilo della costa: Napoleone era dunque arrivato in quello che sarà il suo ultimo dominio. “Il villaggio di Sant’Elena” – ricordò Las Cases nel celebre Memoiral - “non è nient’altro che una strada corta, lungo una valle molto stretta, chiusa tra due montagne a picco su una nuda e sterile roccia”3.
 Gli ufficiali britannici vagliarono quali fossero le possibili dimore per ospitare il celebre prigioniero: Plantation House o la fortezza di Jamestown, non certo dei palazzi di lusso, ma quantomeno dotate di qualche comfort. I carcerieri inglesi però optarono per una soluzione diversa: Longwood House (foto a sx del 1913), un vecchio capannone insalubre che, dopo un sommario rifacimento, sarebbe stato in grado di accogliere il nuovo ospite. Prima di entrare all’inferno, l’imperatore ebbe il piacere di soggiornare per qualche settimana in casa di William Balcombe, provveditore della Compagnia delle Indie e padre della giovane e vivace Betsy, destinata ad entrare nel cuore di Napoleone il quale soleva sempre offrirle le sue amate liquirizie.
Gli ufficiali britannici vagliarono quali fossero le possibili dimore per ospitare il celebre prigioniero: Plantation House o la fortezza di Jamestown, non certo dei palazzi di lusso, ma quantomeno dotate di qualche comfort. I carcerieri inglesi però optarono per una soluzione diversa: Longwood House (foto a sx del 1913), un vecchio capannone insalubre che, dopo un sommario rifacimento, sarebbe stato in grado di accogliere il nuovo ospite. Prima di entrare all’inferno, l’imperatore ebbe il piacere di soggiornare per qualche settimana in casa di William Balcombe, provveditore della Compagnia delle Indie e padre della giovane e vivace Betsy, destinata ad entrare nel cuore di Napoleone il quale soleva sempre offrirle le sue amate liquirizie.
A dicembre, la decaduta corte imperiale, si trasferì definitivamente a Longwood dove le condizioni di vita erano molto distanti dai fasti delle Tuileries. L’ambiente era lugubre, le stanze squallide e mal arredate, cosa che infondeva nell’animo dei suoi ospiti la triste sensazione di dover scontare una pena lunga e disagevole. Napoleone, che non era solito perdersi d’animo, alternava momenti di depressione a stati euforici, soprattutto quando si ritirava nel suo studio, insieme a Las Cases, per dettare le sue memorie. Per sconfiggere la noia, l’imperatore cercò di scandire la sua giornata secondo ritmi ben precisi dai quale non amava discostarsi: pranzo, cena, qualche passeggiata e lunghe conversazioni coi suoi aiutanti, ricordando le glorie passate. Il male peggiore che affliggeva Napoleone era però l’insonnia che lo obbligava a stare in piedi per notti intere peggiorandone l’umore.
Per il resto Bonaparte onorava l’etichetta in vigore a Parigi: tutti avevano il loro posto e qualcosa di cui occuparsi. Per il servizio più intimo dedicato alla sua persona ottenne altresì la presenza di due fidati valletti, Marchand e Saint-Denis detto Alì.
La salute di Napoleone – di giorno in giorno sempre più cagionevole – era tenuta sotto controllo dal dottor O’Meara, un bravo irlandese il quale strinse una sincera amicizia col suo popolare paziente. La sua benevolenza però provocò l’ira del governatore dell’Isola, Sir Hudson Lowe che dal giorno del suo arrivo – il 16 aprile 1816 – cercò in tutti i modi di rendere l’esilio di Napoleone una vera e propria tortura. Tra l’imperatore e Lowe iniziò così un duello interminabile, dove la storia condannò per sempre la figura ambigua del governatore inglese: un uomo povero di intelletto, accusato di essere un incapace e colpevole di aver rifiutato un incarico allo stato maggiore solo per diventare il sadico carceriere di Sant’Elena. Se la storia fu avara di giudizi positivi sul conto di Lowe, sull’isola era comunque lui ad avere l’ultima parola: le misure restrittive a carico del “generale” divennero sempre più asfissianti tanto che, dal 1819 in poi, la salute dell’imperatore subì un declino rapido e preoccupante.

I vari bollettini medici, redatti dal dottor Antommarchi, rilevarono un costante peggioramento del prigioniero il quale sembrava aver perso la sua consueta vitalità, ma cosa ancor più preoccupante i consueti dolori di stomaco, si facevano sempre più frequenti e le medicine facevano sempre meno effetto. Nel corso della sua vita Napoleone soffrì di vari disturbi tra cui la disuria e alcuni gravi problemi epatici, ma nonostante tutto possedeva una formidabile resistenza alla fatica4. Era solito fare lunghi bagni caldi – per mitigare i dolori prostatici – e malgrado i consigli del suo medico personale, Jean Nicolas Corvisart, non risparmiò mai il suo fisico, anzitutto durante le campagne militari. L’avanzare degli anni e lo stress al quale fu sottoposto negli anni di carriera, accelerarono il suo abbattimento e il clima di Sant’Elena gli diede il colpo di grazia.
La notte tra il 3 e 4 maggio, il generale Bertrand notò come le condizioni del suo amato sovrano stessero peggiorando: “l’imperatore ha spesso incrociato le mani sul ventre, intrecciando le dita oppure tenendo le mani aperte; qualche volta cambiava posto alla mano destra sporgendola oltre la sponda del letto. Spesso con la mano sinistra, prendeva il fazzoletto per asciugarsi la bocca dopo avere sputato”5. In quella triste giornata il dottor Francesco Antommarchi e Archibald Arnott – medico inglese al servizio di Lowe – gli somministrarono altri placebo, ma senza alcun risultato apprezzabile.
Alle 5,49 del 5 maggio 1821 l’imperatore Napoleone esalò l’ultimo respiro. Bertrand registrò nelle sue memorie gli ultimi istanti di vita di un grande sovrano che, poco prima di abbandonare la vita, mormorò le parole “alla testa dell’armata”. Quello fu il posto a lui più caro. Solo nei concitati momenti della battaglia, tra il fuoco e le palle di cannone, Napoleone realizzò appieno il suo essere uomo, imperatore, ma soprattutto soldato tra i soldati. Dio di una guerra che gli regalò l’immortalità nel cuore dei suoi soldati, ma non la lungimiranza nelle corti dei politici sebbene, ancora oggi, siano pochi coloro che riescono a sottrarsi al suo indiscutibile fascino.
1 Jospeh Fouché, Mémoires, Paris, Jean de Bonnot, 1967, p. 424.
2 Dominique de Villepin, I cento giorni o lo spirito di sacrificio, Roma, Edizioni dell’Altana, 2005, p. 406.
3 Las Cases, Mémorial de Sainte-Helene, Paris, Bossange, 1823-1824, vol. I, p. 324.
4 Luois Chardigny, Napoleone privato,Milano, Rusconi, 1989, p. 10.
5 Bertrand, Quaderni di Sant’Elena 1816-1821, Milano, Longanesi, 1964, p. 1336.